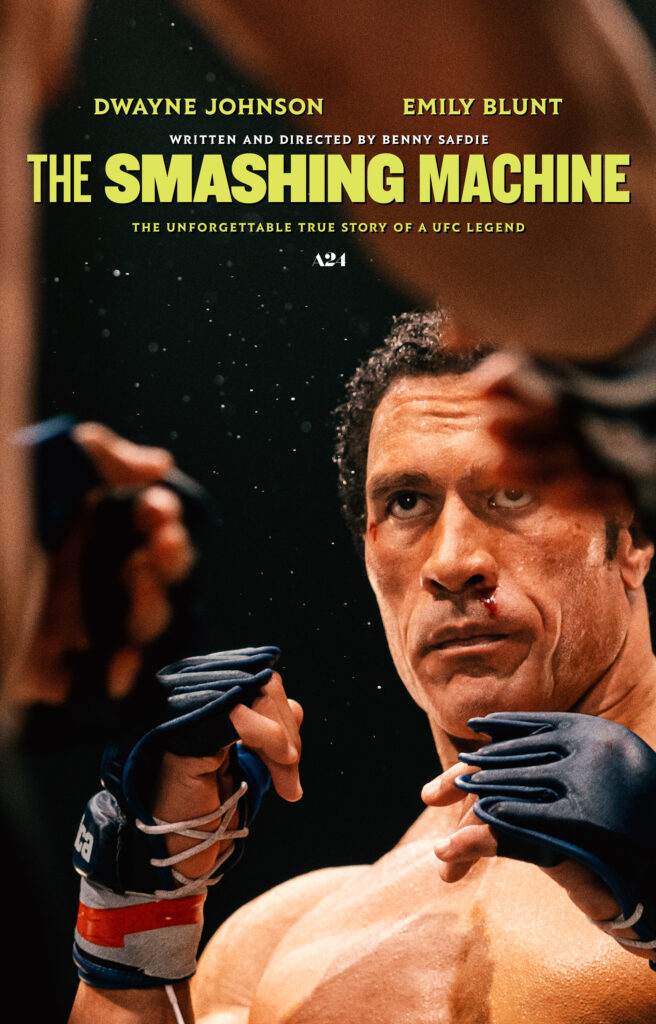Presentato fuori concorso all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, Dead Man’s Wire è l’ultimo film di Gus Van Sant, ma inizialmente il progetto era stato collegato all’interesse di Werner Herzog e al coinvolgimento di Nicolas Cage nelle vesti del protagonista.
E scoprendone l’origine – uno di quei casi cronaca talmente assurdi da diventare surreali per poi trasformarsi in momenti rivelatori di un certo spirito del tempo – se ne capisce il motivo: nel 1977 Anthony G. “Tony” Kiritsis, prese in ostaggio il figlio del presidente della Meridian Mortgage Company, convinto di essere stato truffato, umiliato e svilito per una questione di mutui e investimenti sfilatigli da sotto il naso. La modalità però è molto particolare e ci riporta al titolo: un fucile a canne mozze calibro 12 collegato proprio con un “dead man’s wire”, un cavo teso dal grilletto al collo di Hall pronto a partire nel caso avesse fatto movimento inconsulti.
Ancora più folli però le richieste: non soltanto cinque milioni di dollari di risarcimento e la completa immunità per quanto aveva compiuto, ma anche le scuse personali del presidente Hall per averlo truffato.
L’avvio della pellicola è nervosissimo, pieno di tagli e salti improvvisi, su una musica dell’epoca e la voce calda di un dj che ritornerà nel corso del film. Un avvio in parte mistificatorio, in quanto nello svolgimento registico entrerà un altro elemento caratterizzante, che ci riporta vagamente a quanto fatto in No di Larrain: ovvero l’inserto di (sparute) piccole sequenze o frame, che ci riportano ai notiziari del tempo e alla copertura mediatica, nonché alle fotografie in bianco e nero che probabilmente incorniciarono la vicenda.
L’intento evidente è quello di potenziare il realismo della vicenda, che all’inverso è messa in scena con un sapido gusto per il grottesco – sono moltissimi i momenti che strappano più di una risata, soprattutto per la personalità istrionica e sopra le righe del protagonista – e un’attenzione molto divertita alla ricostruzione di un’epoca molto più libera e interessante degli Stati Uniti.
Altro elemento distintivo di questo film, il cui dipanarsi è piuttosto prevedibile nelle linee generali (è pur sempre una storia vera), è una sorta di gara degli attori alla ricerca dell’accento o della caratterizzazione più marcata. Inutile dirlo, la competizione è vinta dal protagonista Bill Skarsgard, alla sua prova migliore in carriera, il quale ha gioco facile con la sua recitazione solitamente sopra le righe; un ottimo secondo Al Pacino, protagonista di un pugno di scene in cui pur col pilota automatico dimostra quanto sia sempre uno dei migliori. Il resto del cast segue la scia, con risultati ben più che soddisfacenti.
Dead Man’s Wire è progettato per essere un’opera in grado di conquistare piuttosto facilmente il cuore del pubblico, grazie a un ritmo sostenuto, una storia interessante, virate sentimentali e caratterizzazioni facili ma efficacissime: sa quindi commuovere, intrattenere, divertire, mantenere una tensione quasi costante e sa far parteggiare per un protagonista che è un anti-eroe scomodo, un personaggio che si proclama eroe del popolo, ma i cui metodi, e in fondo anche le finalità, appaiono ben più che discutibili. Il film appartiene al corpus più mainstream delle opere di Van Sant e la sua collocazione fuori concorso ci pare più che giusta, in quanto, nonostante la buona mano e le trovate di regia segnalate, manca del tutto la ricerca delle sue prove più sperimentali.
L’elemento più intrigante è con ogni probabilità la natura sfuggente del protagonista, un personaggio semplicemente “larger than life”, che sfugge alla normale caratterizzazione di un criminale: questo mix di follia, romanticismo, totale sconnessione dalla realtà, ossessione per i media, attrazione per una figura paterna desiderata e poi rifiutati, pragmatismo è ciò che di sicuro avrà stimolato la curiosità di Herzog, dato che parrebbe uscito da un suo film. Se non rimpiangiamo quanto fatto da Van Sant, in una reinterpretazione civile comunque stimolante, che insinua a momenti quasi un lieve legame omoerotico tra vittima e carnefice, ci rimane il dubbio sull’ipotetica versione del tedesco.
Le immagini finali, come da copione, ci mostrano sia le riprese dell’epoca che i protagonisti reali ed è innegabile lo sforzo compiuto dai reparti tecnici e dagli attori nel restituire fedeltà a una vicenda che rappresenta un altro tassello della rappresentazione dei nefasti effetti dell’american way of life sui più deboli.